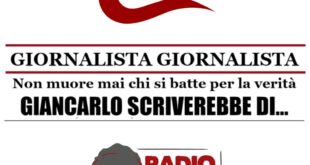“L’Antimafia parola per parola. Conoscere per resistere”, edito dalle edizioni LiberEtà , è un lavoro che nasce dallo sforzo e l’impegno molteplice, di mani e di passione, contro le mafie e l’illegalità. Un percorso voluto ed intenso, che ha coinvolto lo Spi Cgil, elaborando un volume pensato come strumento trasversale contro la criminalità. L’esigenza di partire dalle parole, per conoscere e divulgare, in cui esperti,docenti,sindacalisti e formatori e attivisti hanno ripercorso il percorso dell’antimafia sociale, tra vittorie del passato e obbiettivi futuri, con la consapevolezza e l’importanza di saper parlare alle nuove generazioni , del cancro mafioso, in modo chiaro, semplice e divulgativo.
Nella dicitura del volume, sorprende il sottotitolo “Conoscere per Resistere”. Quanta è fondamentale, oggi, la parola conoscenza nell’ambito dell’antimafia sociale?
La conoscenza è ciò che ci permette di capire con cosa abbiamo a che fare quando si parla di fenomeno mafioso. Abbiamo voluto creare un dizionario proprio per questo: sapere come le mafie si strutturano ci permette di affrontarle e batterle. È un dizionario ragionato, politico se vogliamo. Dobbiamo riappropriarci delle parole, anche di quelle che ci fanno paura. Le mafie vivono di silenzi e noi abbiamo il compito di parlarne, di alzare la voce. Anche perché le mafie evolvono in fretta e noi dobbiamo evolvere più velocemente di loro nella comprensione del fenomeno.
Nella costruzione del dizionario, quali sono stati i tempi di ricerca e di elaborazione?
È stato un lavoro lungo. A creare il prodotto che oggi vedete ci abbiamo impiegato quasi due anni, senza contare che il progetto si inseriva in una precedente versione di diversi anni fa. Ma è stato giusto utilizzare tutto il tempo necessario, perché per noi la priorità era creare un libro credibile e soprattutto utile. C’è voluto tempo anzitutto per decidere quali parole inserire e analizzare: includere tutti i vocaboli relativi alle mafie sarebbe stato quasi impossibile. Abbiamo scelto ciò che secondo noi era più utile per diffondere consapevolezza. Poi c’è stato un tempo lungo per la ricerca e la scrittura, anche perché al dizionario hanno collaborato magistrati, giornalisti, esperti in generale che hanno dato rilevanza a ciò che leggete oggi. E infine il tempo per l’impaginazione, la veste grafica e tutto ciò che era necessario ad una diffusione agevole.
Il volume, unisce la conoscenza delle figure più “anziane”al movimento dei più giovani. Che rapporto si è creato tra i due mondi nella fase di costruzione del volume?
Da tanti anni il Sindacato dei pensionati della Cgil fa del lavoro coi giovani la propria ricchezza.È quella che chiamiamo “intergenerazionalità”, che per noi è diventata una vera e propria bussola nelle azioni che ci riguardano. Il dizionario è stata l’ennesima occasione per dimostrare che le due generazioni hanno molto più in comune di quanto si creda o si faccia credere. I bisogni di chi ha già vissuto una parte della propria vita e di chi ne deve vivere ancora molta sono molto vicini tra loro e spesso le persone non lo sanno. Noi proviamo a spiegare perché ha senso andare oltre gli steccati.
Ogni cosa che facciamo per noi deve avere un duplice sguardo: quello delle persone anziane e quello delle persone giovani. Solo così potremo cambiare il mondo.
Quale ruolo, se vogliamo storico, ha avuto il sindacato nella lotta alle mafie?
I sindacalisti sono stati tra le prime vittime delle mafie. Ma è naturale, purtroppo, che fosse così. Il sindacato è sempre stato in prima linea contro i privilegi e questo ha sempre conflitto con gli interessi dei mafiosi. Quando nel Secondo dopoguerra i contadini chiedevano terre il sindacato ne era il principale rappresentante. Le mafie non hanno mai potuto accettare la presenza di un soggetto che interferisse coi propri affari e si mettesse a redistribuire terre e diritti. E così Placido Rizzotto, Vincenzo Di Salvo, Antonio Esposito Ferraioli e tanti altri sono stati i primi bersagli delle mafie. Oggi noi abbiamo il compito non solo di rinnovare la loro memoria, ma soprattutto di farne lotta quotidiana affinché ciò che rivendicavano allora si ottenga oggi.
La stagione post anni 90′, si sviluppo in un movimento dal basso. Che passaggi storici possiamo trovare all’interno del volume di quella fase?
Quella fase occupa una gran parte del volume. Non perché ciò che c’è stato prima o dopo sia meno importante, ma perché quella è stata per gran parte della società italiana la stagione della consapevolezza di fronte all’evidenza. Per noi è stato importante inserire e analizzare la Trattativa Stato-Mafia, per esempio. Siamo un sindacato e quindi un corpo sociale, che lavora con le persone ogni giorno per migliorare la loro vita, non possiamo non affrontare i chiaroscuri che hanno riguardato le istituzioni del nostro Paese. E sempre parlando di persone, quella è stata la stagione del riscatto collettivo, specie nelle giovani generazioni di allora. Il libro è scritto insieme alla Rete degli studenti e all’Unione degli universitari, i sindacati studenteschi più grandi del Paese, che sono nati tra le altre cose proprio in seguito a quella stagione di enorme partecipazione. L’antimafia sociale ce l’abbiamo nel dna.
Le mafie cambiano attualmente, sia forma che identità. Quali sono le sfide future della cultura antimafia dal valore sociale?
Le mafie oggi non sparano ma questo non vuol dire che non esistano. Sono silenziose perché hanno cose più importanti da gestire. I loro affari nell’economia sommersa e quella a metà tra il visibile e l’invisibile hanno bisogno di non avere disturbi. La sfida è acquisire conoscenza e consapevolezza, specie nelle istituzioni pubbliche. Il nostro ruolo è quello di continuare a parlarne, di non cedere a questi silenzi rumorosissimi. Abbassare la guardia oggi significa permettere alle mafie di avanzare e prendere spazio negli appalti, nelle interferenze con la politica, nei commerci leciti e illeciti. Noi siamo la resistenza più vera e tangibile alle nuove mafie.
Sergio Cimmino
 Radio Siani la radio della legalità
Radio Siani la radio della legalità